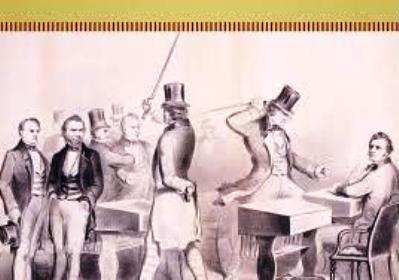scritto da Luigi Gravagnuolo per Salernonews24 il 16.11.21
 Pioveva a Cava de’ Tirreni l’11 novembre 1930, quando di buon mattino, provenienti in treno da Napoli, scesero alla stazione tre persone. Il più alto e robusto aveva un cappello tipo Borsalino a tesa larga e, nelle tasche del soprabito, una guida Touring dell’Italia meridionale. Gli altri due erano il maresciallo Sarti ed il brigadiere Longari. I due scortavano Bortolo Belotti, una delle personalità più rilevanti dell’Italia pre-fascista, deputato per tre legislature, sottosegretario nei governi Nitti e Giolitti, ministro nel governo Bonomi. Era lui quello alto col borsalino in testa.
Pioveva a Cava de’ Tirreni l’11 novembre 1930, quando di buon mattino, provenienti in treno da Napoli, scesero alla stazione tre persone. Il più alto e robusto aveva un cappello tipo Borsalino a tesa larga e, nelle tasche del soprabito, una guida Touring dell’Italia meridionale. Gli altri due erano il maresciallo Sarti ed il brigadiere Longari. I due scortavano Bortolo Belotti, una delle personalità più rilevanti dell’Italia pre-fascista, deputato per tre legislature, sottosegretario nei governi Nitti e Giolitti, ministro nel governo Bonomi. Era lui quello alto col borsalino in testa.
Di carattere fiero ed altezzoso, considerava gli uffici dello Stato alla stregua di un sacerdozio, nutriva un sacro pudore verso i conti pubblici. Pur non essendo un antifascista, aveva denunciato l’uso delle cariche pubbliche a fini di arricchimento personale, al quale si erano lasciati andare tanti degli ‘uomini nuovi’ della politica di quei tempi, quelli in camicia nera. Aveva infine toccato un filo scoperto, quando aveva smascherato le malversazioni degli amministratori della Banca Italiana di Sconto e si era opposto al suo salvataggio da parte dello Stato. Non sapeva che i Perrone, azionisti di quell’istituto di credito, erano tra i principali finanziatori del duce. Fu arrestato, processato senza alcuna regolare procedura giudiziaria, e condannato a cinque anni di confino a Cava de’ Tirreni. I due militi di scorta che lo accompagnarono avevano il compito di consegnarlo al Commissario di Polizia a Cava, cosa che fecero subito dopo che il confinato ebbe consegnato i bagagli all’Hotel de Londres e consumato con loro la prima colazione.
Belotti – giurista di altissimo livello – visse il suo arresto e la sua condanna alla stregua di Josef K., il protagonista del Processo di Kafka. Nessuno gli aveva comunicato i motivi dell’arresto, non gli era stata garantita l’assistenza di un legale, non gli era stato contestato alcun reato. Per se stesso era peraltro ignaro di essere un antifascista. Un non-fascista sì, ne era consapevole, un anti-fascista no. Ingenuamente pensava che smascherare i profittatori del regime potesse essere cosa gradita addirittura al duce, che di certo non poteva sapere tutto di tutti. Aveva servito la patria in guerra e al governo, aveva finanche partecipato alla compagine parlamentare liberal-fascista della XXVI legislatura, la prima i cui deputati furono eletti a suffragio universale maschile. Da uomo di governo aveva spaccato il quattrino in quattro per tutelare i soldi degli Italiani. A tutt’oggi i motivi reali della sua condanna restano solo supposti, non essendo stato formulato nei suoi confronti alcun puntuale capo di imputazione.
Fatto sta che passò sei mesi a Cava da confinato. Ci era arrivato, da bergamasco della Val Brembana, con tutto il carico di albagia verso i meridionali, propria di quei valligiani polentoni. L’Hotel de Londres era un albergo di prima classe, oggi diremmo a cinque stelle, e Cava era una cittadina amena, con un centro elegante e villaggi incantevoli, a pochi passi dalla Costiera Amalfitana, Pompei e Paestum, località alle quali non gli fu peraltro mai permesso di recarsi. Ma lui stette male a Cava, specie nelle prime settimane. Sentiva l’ignominia di essere considerato un delinquente, e poi, detestava noi meridionali, la nostra parlata ed i nostri odori, sentiva la lontananza da Milano e della val Brembana come una lacerante ferita. Un poco alla volta, si ambientò.
Pur spiato ed osservato, come tutti i confinati, potette accogliere all’Hotel de Londres sua moglie Angelica, la figlia Bianca Maria e la donna di servizio. Poté ricevere visite di amici provenienti da Roma o da Napoli – beninteso, quelli che non temettero di essere schedati come collusi con un antifascista – e instaurò rapporti di sincera amicizia con il dottore Giovanni Pisapia, direttore sanitario dell’Ospedale della Santissima Incoronata dell’Olmo, e con i Tajani di Vietri sul Mare, i Balestrieri e pochi altri.
Il giorno del sabato santo del ‘31 il commissario gli comunicò che il duce, con un atto di clemenza, gli aveva rimesso la libertà. La mattina di Pasqua seguì alla Madonna dell’Olmo la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Dell’Isola, quindi corse a preparare i bagagli.
Tornò alla sua casa di Milano il lunedì in Albis, avendo maturato nel semestre cavense una diversa stima del Mezzogiorno. Una roba da Benvenuti al Sud ante litteram. Non solo, arrivato a Cava non-fascista, ritornò a Milano anti-fascista. Troppo grande era stata l’ingiuria verso la sua persona. Ma com’era Cava tra la fine del ‘30 ed i primi mesi del ‘31? Ce la racconta lui stesso nel suo diario (Belotti B., Confinati dal Duce – Memorie del mio confino a Cava de’ Tirreni 1930-31, Verona 2011).
È appena il caso di ricordare come, sulla sua vicenda, abbia speso pagine esemplari la compianta Patrizia Reso nel suo Il Fascismo e Cava città di confino, Salerno 2017.
Ma torniamo a Cava nel novembre del ‘30. Intanto era piovosa, e questo non è cambiato in questi novanta anni. In Piazza Duomo c’era ancora l’antico episcopio ed i portici erano quelli dei secoli precedenti. Non erano ancora stati oltraggiati dalla nuova edilizia degli anni sessanta. Chissà come dovevano essere suggestivi!
Belotti visitò i Cappuccini, l’episcopio, le chiese del centro, il presepio di San Francesco, la biblioteca Avallone, e l’abbazia benedettina. Qui avrebbe gradito visionare il celeberrimo archivio annesso alla biblioteca, ma i monaci furono restii a consentirglielo. Anche questo non è cambiato da allora.
Si spostava per la valle sulle carrozze con i cocchieri che stazionavano, a mo’ dei moderni taxi, alla stazione e in piazza Roma, oggi piazza Abbro. Per strada, anche lungo il corso porticato, circolavano numerosi asinelli condotti dai paesani. Sua figlia Bianca Maria, di otto anni, si divertiva a contarli, annotandone il numero quotidianamente su un suo diario.
Soprattuttosi avvertiva a pelle, palmare, la dicotomia tra le classi sociali. Al centro c’erano le residenze dei redditieri agrari, dei professionisti, di qualche commerciante e del popolino dei ‘bassi’ con le botteghe artigiane. Nelle frazioni vivevano i contadini. Solo a Rotolo e a Castagneto, pur frazioni, insistevano prestigiose ville signorili.
Il sabato e la domenica dalle frazioni i parzunari scendevano in ‘piazza’ per il passeggio sotto i portici ed i signori, per non sentirne la puzza, non uscivano di casa.
Abbiamo accennato all’amicizia col dottore Pisapia, direttore dell’ospedale, con il quale il Nostro dialogò frequentemente. Già, l’ospedale, la gente si lamentava perché c’era carenza di personale medico ed infermieristico e i reparti non erano adeguatamente dotati di attrezzature mediche. Anche questo non è cambiato.