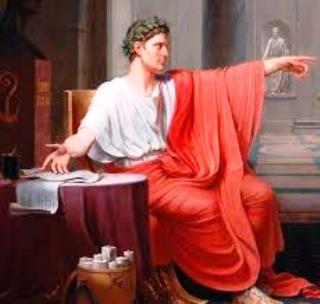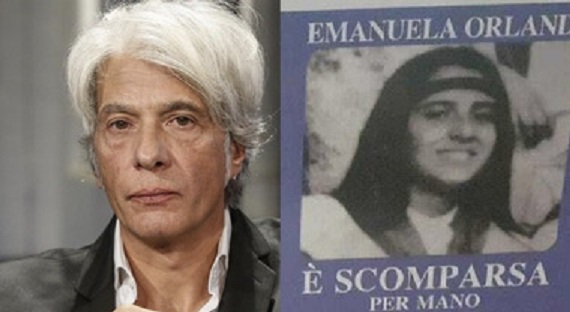da Angelo Giubileo (avvocato – filosofo)
Stamattina, un amico mi ha inviato mediante social un articolo del giornalista Enzo d’Errico, che scrive per il Corriere del Mezzogiorno, dal titolo, almeno per me, piuttosto intrigante: I misteri del potere (I misteri del potere | Corriere.it).
Leggendo l’articolo, mi ha colpito l’insistenza con la quale il giornalista si è per l’appunto interrogato, apparentemente senza risposta, sui misteri del potere in ordine alle vicende trattate.
E allora, sapientemente, sono andato a rileggere le parole di Platone nel Sofista (247d-e): ciò che è è ciò che ha potere di fare o di essere fatto. Così che Il filosofo definisce l’intero “essere” come dynamis, termine traducibile con il significato senz’altro più appropriato di “potenza”.
La storia del rapporto tra potere e sapere risale a epoche remote ed è altresì comune a tutte le tradizioni o civiltà che si sono susseguite nel “tempo”. In ambito “classico” – greco, latino e poi cristiano – l’origine della narrazione e dell’interrogazione sul rapporto medesimo risale ai facimenti e rifacimenti di un testo meglio noto come Romanzo di Alessandro.
In particolare, il testo narra di un colloquio, avvenuto molto presumibilmente, tra il re conquistatore Alessandro e i gimnosofisti o sapienti indiani. Nel merito, Chiara Di Serio, una specialista di antichità classiche, ha pubblicato di recente un eccellente saggio dal titolo Alessandro e i Brahmani. La costruzione di un’alterità ideale dalla Grecia antica al Medioevo (Bulzoni 2024).
Consigliando vivamente la lettura del saggio, riporto qui in estrema sintesi uno dei tanti giudizi desumibili dal testo del Romanzo: “si può osservare che nessuno degli interlocutori prevalga sull’altro: da una parte il sovrano mantiene intatta la propria sfera d’azione, ovvero l’esercizio del comando, dall’altra i saggi indiani dimostrano la loro superiorità intellettuale, praticando la filosofia”.