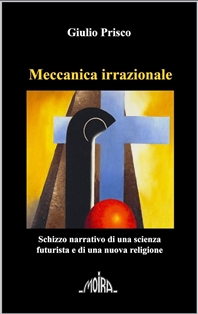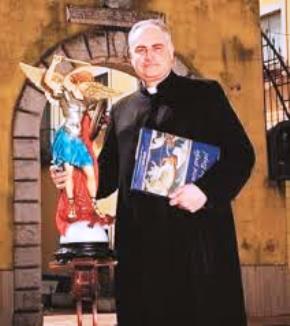da Angelo Giubileo (avvocato – filosofo)
Ogni rito, che noi diciamo “religioso”, ha invece un’origine e un significato che noi stessi diciamo “scientifico”. L’origine di questa spiegazione è nota a Plutarco, che la esplicita nel suo “Iside e Osiride” (Adelphi 2019) nel modo che segue.
Plutarco scrive: “… noi comprendiamo l’essere se sapremo accostarci con spirito razionale e al tempo stesso devoto ai riti della dea (Iside)” (Ib. 2, 352). Caratteristica di siffatto spirito razionale, dice sempre Plutarco, è quella di contrapporsi a uno spirito viceversa “irrazionale, fantastico e di tipo superstizioso”. Così che egli stesso conclude: “Nei loro riti religiosi (gli Egiziani) non si è mai introdotto, come invece alcuni ritengono, alcun elemento irrazionale, fantastico e di tipo superstizioso: al contrario, certi riti nascono da ragioni morali o pratiche, altri, se pure non privi di una graziosa spiegazione, hanno però motivazioni storiche o fisiche …” (Ib. 8).
E quanto alla nozione di spirito, sempre Plutarco, aveva già chiarito: “la tensione verso il vero, e soprattutto il vero riguardo agli dei (che Aristotele, nella Metafisica, aveva già identificato con l’insieme di tutte le cose naturali; cfr. G. de Santillana-H. von Dechend, Il mulino di Amleto, Adelphi 2000, p. 181), è desiderio di divinità: l’apprendimento e la ricerca che tale tensione comporta, infatti, costituiscono quasi un acquisto di virtù divine, ed è un’iniziativa spirituale, questa, ben più santa di qualsiasi forma di castità e della continua pratica religiosa” (Ib. 2).
E quindi Plutarco fa espressamente riferimento a un’iniziativa che noi oggi invece diciamo di ricerca e analisi scientifica del vero della Natura. In linea di continuità con la tradizione di pensiero esplicitata da Plutarco, lo storico della scienza Giorgio de Santillana ha detto che: “Le conquiste della scienza greca (ndr: ultima tradizione in senso storico-cronologico) (e) lo spirito di quelle conquiste si conservò intatto, nel periodo intermedio (fino al Settecento u.s.), in alcune grandi dottrine scientifico-filosofiche che avevano veramente un contenuto religioso e quindi non solo orientarono ma plasmarono il pensiero occidentale nel difficile periodo di transizione” (G. de Santillana, Le origini del pensiero scientifico, Sansoni editore 1966, p. 293).
Da notare che Giorgio de Santillana dice qui riguardo alla tradizione del pensiero occidentale, ma noi sappiamo, anche grazie a lui e a Hertha von Dechend, che la stessa tradizione del pensiero occidentale è erede piuttosto della tradizione senz’altro parsi e, entrambe, della tradizione hindu forse originaria (cfr. G.B. L. Tilak).
Ma, dice ancora de Santillana, nel brano che immediatamente segue: “Esse (le grandi dottrine scientifico-filosofiche) furono, per così dire, le onde portanti. E’ attraverso di esse che si mantenne la continuità, e senza di esse gli ulteriori sviluppi rimarrebbero incomprensibili” (Ib.). E quindi, in definitiva, una tradizione del pensiero occidentale – che sia Tilak che gli Autori di Il mulino di Amleto dimostrano come in effetti abbia “tradito” le origini della vera tradizione – che, schematicamente, è rappresentata da “tre forme di religione scientifica: atomismo, stoicismo e neoplatonismo” (G. de Santillana, op. cit., p. 293).
E pertanto, nient’altro che forme diverse di un unico pensiero scientifico che l’uomo tramanda da sempre; così che scrivono gli Autori di Il mulino di Amleto: “l’umanità è il prodotto di un lunghissimo processo di trasmissione e accrescimento, di perdita e di ri-nascimento delle conoscenze scientifiche” (G. de Santillana-H. von Dechend, op. cit., p. 417). Fino a oggi, e cioè alle soglie di una nuova rivoluzione o religione scientifica guidata, da oltre un secolo, dai fisici quantistici. Come lo stesso fisico Giulio Prisco, autore del saggio Meccanica irrazionale. Schizzo narrativo di una scienza futurista e di una nuova religione”, così che sia a tutti chiaro che trattasi di un pensiero scientifico che nulla ha a che fare con la superstizione dei riti o pratiche religiose.