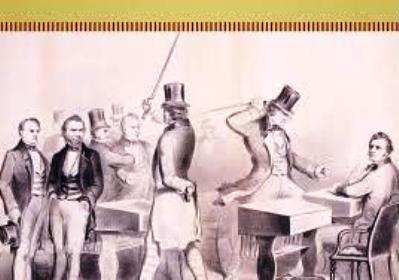Avv. Giovanni Falci
(penalista – cassazioni sta)

A Salerno, nella vita professionale di un avvocato, non figlio d’arte, cioè con genitori o parenti nel settore, il successo, agli inizi degli anni ’80, si costruiva, e forse lo si fa ancora oggi, gradualmente, attraverso la “fama” che passa di bocca in bocca, legata a importanti risultati ottenuti in Tribunale: il successo si conquistava sul campo.
Devo dire che per un penalista, era più semplice potersi ”mettere in mostra” invece che per un civilista, specie quando ho iniziato io, 1979 in Pretura e 1982 in Tribunale.
L’oralità del rito, l’arringa, si faceva in udienza e veniva ascoltata dal pubblico presente che generalmente tifa per l’avvocato visto come un novello Davide di fronte al Gigante Golia impersonato dal P.M. organo della potenza dello Stato.
Del resto chi di noi non ha tifato per Perry Mason nel vedere i suoi sceneggiati televisivi? (e questo a prescindere dal ritenere o meno colpevole il suo cliente).
Oggi anche si discute la causa oralmente in udienza, ma l’arringa non ha quella funzione centrale per la difesa; oggi la causa si costruisce durante il dibattimento in cui l’avvocato ha un ruolo molto attivo nella formazione della prova e perciò, la discussione si riduce ad una sintesi e un riassunto di quanto già fatto in precedenza nel corso delle varie udienze di trattazione; oggi il giudice sa già cosa dirà l’avvocato quando prenderà la parola per discutere la causa, lo ha capito durante il processo quale sarà la sua tesi e la sua strategia.
Il processo si realizza e si costruisce in aula attraverso l’esame e il controesame di testi del PM e della difesa (a volte e raramente anche testi del Tribunale), consulenti, periti, collaboratori di giustizia etc.; prima invece tutto questo “materiale probatorio” veniva “impacchettato” dal Giudice Istruttore che lo consegnava al Tribunale e c’era poco margine di manovra sia per l’accusa ma soprattutto per la difesa.
Il civilista, invece, con il proprio operato svolto prevalentemente per iscritto, aveva e ha meno possibilità di “esibirsi”.
Devo dire che ho sempre pensato che la differenza che esiste tra un avvocato civilista e uno penalista, è la stessa che esiste tra un attore di cinema e uno di teatro.
Il penalista si “esibisce” davanti al “pubblico” (il tribunale) presente in aula come l’attore si esibisce in teatro davanti al pubblico fisicamente presente davanti a lui; il civilista, invece, si “esibisce” per iscritto e quando la sua “performance” verrà letta dal suo “pubblico” (il giudice a casa), lui non sarà presente e ci sarà la freddezza di un foglio a mediare, così come c’è la freddezza dello schermo al cinema.
Certo, è vero, il civilista ha più tempo per riflettere, correggere, modificare, ritornare su un punto etc. (oggi con il pc è ancora più semplice questa operazione di cesellatura), però, una volta consegnato il suo elaborato, non avrà più possibilità di intervenire: o è perfetto o si frega; e così appunto è anche l’attore di cinema: puoi provare decine di volte la scena, però quando si finisce di girare, o è perfetta o ti freghi.
Il penalista invece, ha la possibilità di comprendere, mentre si “esibisce”, se sta andando bene o meno, di capire se è il caso di insistere su un punto o tralasciare un altro, ha, in definitiva, la possibilità di tastare il polso del pubblico (sa anche quando, se fosse possibile, riceverà fischi o applausi); il suo pubblico è coinvolto fisicamente nella sua opera, è, perciò, più incline anche a lasciare passare un errore, a volte neanche si percepisce in teatro l’errore dell’attore, si è più indulgenti; si sente la voce cambiare nel corso di lunghe discussioni, si vede il rivolo di sudore sulla tempia, ci si stanca insieme.

Perciò sono convinto che la professione di avvocato civilista è più difficile di quella del penalista; c’è meno indulgenza e maggiore critica dell’operato dell’avvocato riversato in atti e comparse scritte.
Come dire alla carta del civilista si contrappone la carne del penalista!
Detto questo, il mio ingresso nel processo passato alla storia come il “processo Tortora”, fu appunto il frutto di una causa che avevo vinto in Corte di Assise insieme al prof. Giuliano Vassalli (legittima difesa reale per un triplice tentato omicidio) che era stata molto pubblicizzata dalla stampa e da “radio carcere”.
Il 17 giugno 1983 tra gli 855 ordini di cattura, emessi dal giudice istruttore, il dott. Giorgio Fontana, del Tribunale di Napoli su indagine dei due sostituti procuratori Lucio Di Pietro, definito “il Maradona del diritto”, e Felice Di Persia, venne arrestato anche P.A. di Nocera Inferiore.
A fine giugno, dopo una decina di giorni da quella maxi operazione che ebbe una eco incredibile anche e soprattutto per l’arresto di Enzo Tortora il noto presentatore televisivo di tante trasmissioni di successo dalla Domenica Sportiva a Portobello, fui contattato da un mio fraterno amico di Nocera, all’epoca anche esponente nel Consiglio Comunale, il quale mi disse che una signora anziana, madre di un arrestato nel “blitz Tortora”, le aveva chiesto chi fosse l’avvocato che aveva fatto assolvere il padre e di cui si era tanto parlato in città; era sua intenzione conferirmi il mandato affinché difendessi il figlio rinchiuso a Poggioreale in quella che era diventata ancora di più, per l’arrivo contemporaneo di centinaia di arrestati, una bolgia dell’inferno dantesco con santa pace della CEDU e della convenzione per la difesa diritti dell’Uomo.
Mi dichiarai disponibile e ricevetti questa signora anziana che mi prese le mani in mano e piangendo mi chiedeva di “salvare il figlio” che era un bravo ragazzo “sfortunato”.

In effetti, per le madri, i figli arrestati sono sempre “sfortunati”, “innocenti”, “bravi ragazzi che non farebbero male a una mosca”, che si trovano in carcere per colpa delle “cattive compagnie”.
La rassicurai e ricevetti dopo qualche giorno presso l’Ordine degli avvocati di Salerno, la nomina di P.A. che aveva fatto all’ufficio matricola del carcere.
Con quella nomina mi recai a Poggioreale per conoscere P.A..
Ricordo quella prima volta che varcai quella porta molto grande, verde, ma che si apriva solo in parte e dovevi quasi genufletterti per oltrepassarla.
Ricordo ancora l’odore di “cucinato” di “sugo”, di “pasta asciutta”, che sembrava avere impregnato le pareti. Non è mai cambiato quell’odore in tutte le volte che negli anni successivi sono stato in quel carcere.
Dopo il controllo del tesserino in custodia di pelle rossa con le firme del Presidente De Nicolellis e del Direttore Ferrari (il mio ancora lo conservo nonostante ora è stato sostituito con uno in platica tipo carta di credito), ci si incamminava in un corridoio ampio dove, più o meno a metà, c’era una scultura di Gesù crocifisso di grandi dimensioni che, sarà stato per il luogo, sembrava più sofferente che in altre rappresentazioni e in altri contesti.
Subito dopo, sulla sinistra, attraverso un porta segnalata da una guardia carceraria (così si chiamavano allora), si saliva al primo piano attraverso due rampe di scale ben disegnate e con una ringhiera di ghisa, stile liberty, veramente bella.
Al primo piano si entrava nella “sala di attesa avvocati”, si dava il nominativo del proprio cliente all’agente preposto e si aspettava, insieme ai colleghi già presenti e a quelli che sopraggiungevano, seduti intorno a un grande tavolo nella “sala avvocati”.
Ricordo che c’erano molti avvocati perché l’operazione era stata veramente imponente.
C’erano quelli sicuri di se che parlavano un po’ ad alta voce, c’erano quelli che sapevano già tutto ed erano informati dal “giudice”, c’erano quelli anziani e quelli, come me, giovani, io forse ero il più giovane lì dentro; molti si conoscevano tra di loro e si scambiavano battute; io non conoscevo nessuno, ma tutti mi sorridevano.
In effetti c’era, forse oggi un po’ di meno, una certa complicità di tipo goliardico tra gli avvocati.
Basta non toccare la tasca del collega, per il resto ci sarà sempre spazio per solidarietà e colleganza.
Quando fu il mio turno, chiamato ad alta voce dal secondino, conobbi P.A. in una sala colloqui di 5/6 mq (non capirò mai perché con tanto spazio nei corridoi e in tutto quel settore, le salette dei colloqui fossero così minuscole).
P. mi fece una buona impressione.
Era mio coetaneo, non aveva una faccia da “duro”, anzi aveva fisico e volto dai lineamenti delicati, biondino, carnagione chiara, si esprimeva in un italiano corretto e non sapeva come mai era finito in questa storia.
Mi disse che lavorava regolarmente nella accorsata attività commerciale di famiglia; che in passato, ”da ragazzo” (come se allora fossimo stati anziani) aveva fatto qualche “bravata”, ma che era “roba vecchia”; ovviamente conosceva un po’ tutti in paese, “buoni e cattivi”, specie quelli della sua/nostra generazione.
Aveva saputo, come del resto tutta l’Italia, che gli arresti erano avvenuti sulla scorta delle accuse dei c.d. “pentiti” che avevano svelato i nomi degli appartenenti alla N.C.O. (Nuova Camorra Organizzata) che faceva capo al famigerato Raffaele Cutolo detto “u’ professore di Ottaviano”.
Giurava di essere completamente estraneo a questi fatti e, che se anche conosceva qualche “camorrista” di questo gruppo, lui però non aveva mai aderito a queste associazioni per delinquere e non aveva intrattenuto con loro rapporti criminali.
Rimanemmo d’accordo che ci saremmo visti in sede di interrogatorio.
All’epoca non c’era un termine entro il quale una persona arrestata dovesse essere interrogato per potersi difendere; il codice di procedura penale era il vecchio codice Rocco del 1930, un codice che regolava il processo su principi inquisitori per cui vi era uno strapotere del PM e un ruolo marginale della difesa.
Vigeva la presunzione di colpevolezza!
Fosse stato oggi l’interrogatorio si sarebbe svolto entro il 23 giugno 1983 e cioè nei 5 giorni (art. 294 c.p.p.) dopo l’arresto del 17 giugno.
Non che le cose sarebbero cambiate chissà quanto, perché, a prescindere dalle norme, ci sono sempre persone che le applicano e le interpretano non sempre correttamente, da tutte le parti.
Però, se non altro, oggi, un “errore” dovrebbe passare il vaglio di un Tribunale (riesame) e dopo della Cassazione e perciò la maggiore garanzia di libertà del cittadino risiede proprio in questo controllo che si svolge anche in tempi abbastanza rapidi.
Per chi come me ha visto processi con il vecchio e il nuovo rito, sentire quello che oggi si dice sulle “semplificazioni” e sulle riduzioni delle impugnazioni, fa venire i brividi; ma a volte la fonte giustifica il contenuto delle proposte.
Tornando a P. di lì a poco, mi fu notificato l’avviso per la “ricognizione di persona” che si sarebbe svolta a Poggioreale in un pomeriggio agli inizi di luglio.
Con giacca e cravatta, sotto un sole tropicale, a bordo della mia R5 blu metallizzata ultima versione, mi recai a Poggioreale e, nel mentre cercavo un posto per parcheggiare, vidi P.A. davanti il bar di fronte l’ingresso del carcere. Per la verità fu lui a vedermi e a fare ampi gesti con le braccia per attirare la mia attenzione.
Mi avvicinai e lui saltò subito in macchina dicendomi “avvocà andiamo via è finita”.
Lo guardai un po’ tra l’incredulo e il sospettoso e lui, che aveva capito, mi disse: “tutto a posto, u’ nimale mi ha visto e ha detto non è lui il P. che ho accusato è un altro di S….”.
Pensai tra me e me che era pazzesco: la vita di una persona legata alla parola di un altro, a prescindere se delinquente o meno, senza possibilità di difendersi.

Quando poi è legata alle dichiarazioni di Pasquale Barra detto “o ‘nimale” killer dei penitenziari, 67 omicidi in carriera tra cui lo sbudellamento di Francis Turatello al cui cuore diede un morso, la cosa diventa ancora più raccapricciante.
Gli chiesi di spiegarmi come si era svolto il tutto e lui mi raccontò che erano stati fatti passare, una decina di arrestati, uno per volta in una camera del carcere davanti a Pasquale Barra detto u’ nimale che, in mezzo a poliziotti e magistrati o confermava o, come nel suo solo caso, smentiva l’accusa e il giudice decideva di conseguenza seduta stante.
Era da più di un’ora che mi aspettava (oggi con i cellulari non sarebbe avvenuto e mi sarei evitato quel pomeriggio di calore nel quale non feci neanche la mia consueta pennichella).
In realtà, allora, quello di P.A. fu uno dei 216 errori di persona in cui incapparono i P.M., e non so se in questo numero di errori riportato dagli archivi stampa rientri anche quello del mio cliente perché dopo la storia avrà un prosieguo.
Non avevo fatto praticamente niente (se non accompagnare in macchina P.A. a casa sua a Nocera), ma il giorno dopo ero, non solo “quello” dell’assoluzione del triplice tentato omicidio, ma anche “quello” della scarcerazione di P.A. nel processo Tortora.
Il tutto con un cognome poco diffuso al sud e anche difficile da ricordare; mi andava bene se mi chiamavano solo Falce riducendo il mio cognome al singolare (per inciso sono stato chiamato Fracci, Fauci, Franci).
Non vidi più P.A. se non per l’onorario che mi portò in studio insieme alla madre contentissima di avere riabbracciato questo figlio, forse preferito perché “sfortunato”, a modo suo.
Sotto Natale dello stesso anno 1983 fui nuovamente telefonato dalla signora P. che in un pianto che non riusciva a contenere, mi informava che alle 5 di quella mattina erano andati ad arrestare il figlio, “sempre per il processo di Napoli”.
Mi portai a Napoli questa volta con il freddo e la pioggia di dicembre e in cancelleria del Tribunale, nella bellissima ma scomodissima sede di Castel Capuano, ebbi la conferma che P.A. era stato raggiunto da un nuovo mandato di cattura; riuscii a parlare con il Giudice Istruttore che mi disse che un “nuovo pentito” lo aveva accusato di essere un camorrista della NCO.
Approfittai che ero a Napoli e andai a trovare P.A.; varcai per la seconda volta il portone verde scuro.
Quello per me fu un giorno importante perché feci una conoscenza con un collega di Benevento, l’avv. Alberto Simeone, che è durata tutta la vita e continua anche adesso che Alberto è morto il 1 febbraio 2016, continua con la moglie Alma e i figli Licia, Massimiliano e Maria Laura.
Lo ricordo ancora quel giorno con i suoi capelli biondi, gli occhiali con lenti molto spesse e con il suo loden verde come il portone di Poggioreale e con il sorriso che gli ho sempre visto in volto.
Una amicizia speciale, istantanea, immediata.
Benché più anziano di me, e benché si fosse liberato prima, attese che finissi il mio colloquio per prendere un caffè insieme al bar e continuare a parlare; volle il mio indirizzo e numero di telefono; il 31 dicembre mi fu recapitato a casa una confezione di torroni, cioccolatini e liquore “Strega Alberti” di Benevento con un biglietto di auguri che mi commosse.
Alberto diventerà dopo alcuni anni, nel 1994, deputato di AN, un partito distante anni luce dalle mie idee politiche, e sarà autore di una legge che porta il suo nome, frutto anche di quelle esperienze che vivevamo nella “sala colloqui”.
Fece parte della II Commissione permanente Giustizia e fu il primo firmatario di un disegno di legge, approvato a larga maggioranza in parlamento, che rendeva la possibilità di accesso alle misure alternative senza passare per il carcere, (semilibertà, affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare) in caso di condanna uguale o inferiore a due anni di detenzione.
Tale legge (chiamata appunto legge Simeone) fu poi duramente attaccata da membri del suo stesso schieramento politico che l’avevano votata in parlamento, in quanto ritenuta, ottusamente, corresponsabile dell’aumento dei crimini comuni.
Il suo partito ritenne di non ricandidarlo perché aveva fatto una legge “votata anche dai comunisti”.

La persona che nel collegio uninominale di Benevento aveva sconfitto nel 1994 l’on. Gerardo Bianco, segretario di un partito, non avrebbe avuto un seggio per candidarsi, per avere fatto una legge tecnicamente eccezionale, ma “politicamente” inopportuna per uno schieramento di giustizialisti forcaioli.
Come dire che in politica, se bisogna o meno sottoporsi a vaccinazione, dipende da chi propone la legge.
Ma Alberto, al di là dell’avvocato di valore, del politico corretto e per bene, intellettualmente, e non solo, onesto, era un Signore con la S maiuscola.
Era una persona delicata, di grandi sentimenti, era una persona che ho visto commuoversi più volte al racconto di un fatto triste.
Cosa ci facesse in politica una persona del genere non l’ho mai capito, anzi ho capito che per lui non era “quella” la politica, la sua era politica del servizio e della dedizione verso il prossimo, e, meglio ancora se debole, emarginato e abbandonato.
Tornando al processo, questa volta trovai un P. distrutto.
Non riusciva a capacitarsi e, effettivamente, doveva essere una situazione atroce: dopo essere uscito da un incubo, ritornarci di nuovo era insopportabile.
Alla felicità per il pericolo scampato, si contrapponeva di nuovo l’inizio di una tragedia.
Mentre tornavo a casa pensavo che lo stato d’animo in quel momento di P. era paragonabile a quello di Sisifo come descritto da Albert Camus.
Dopo la fatica portata a termine con la scarcerazione di luglio, un nuovo inizio della fatica ancora una volta incerta nel suo divenire e nel suo esito.
Comunque questa volta la storia non finì nell’interrogatorio al quale partecipai.
Non trovai P. fuori al carcere, ma dentro e, nonostante avesse dichiarato di non conoscere il “pentito” che lo accusava e di avere ricevuto una cartolina di auguri natalizi da un detenuto perché suo amico con il quale aveva frequentato anche le scuole medie e non perché suo concorrente nel reato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, P.A. rimase rinchiuso a Poggioreale per tutto il processo che iniziò nel febbraio 1985.
A dopo per il prosieguo.
Giovanni Falci