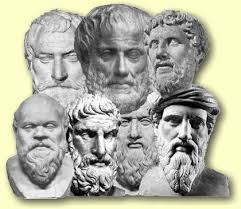 di Angelo Giubileo (scrittore)
di Angelo Giubileo (scrittore)
SALERNO – E’ davvero conclusa la parabola del modo di fare filosofia – che è stato quel modo stesso della filosofia della tradizione risalente a Platone e Aristotele, significativamente definita dei postsocratici per distinguerla dal modo di fare della filosofia cosiddetta dei presocratici, e che è stato fino a circa l’inizio-prima metà del secolo scorso – in base al quale il soggetto che pensa, avulso dal contesto naturale, veniva posizionato, secondo la sintetica e felice espressione di Giovanni Leghissa, “mentre si rapporta al pensato”, e in maniera che ritengo ancora più puntuale: “mentre accede alla concettualità del pensato in quanto tale”.
E’ possibile dubitare di questa fine, così come è possibile che la conclusione, e quindi la fine, di una tale parabola possa, in tutto o in parte, piacere o non piacere. Ma, oltre la dimensione e il gusto estetico, quel che principalmente rileva è la “condizione” attuale, definita postmoderna, che testimonia la fine di questa parabola, e quindi di quel modo in-co-er-ente di fare filosofia.
Si tratta di una condizione nuova o di un ritorno all’antico? Ovvero, al modo presocratico di fare filosofia, al mondo dei primi “fisici”, al pensiero dei “pensatori iniziali” a cui fa riferimento Heidegger e, in primis, a Parmenide? In effetti, è proprio di questa antica prospettiva che qui principalmente si tratta, e cioè essenzialmente di questo ritorno al modo antico di fare filosofia.
Non a caso uno dei maggiori fisici (e divulgatori di scienza) viventi, Carlo Rovelli sottolinea oggi che nel Protrepticus, opera di cui secondo la tradizione si erano finora per così dire perse le tracce (www.protrepticus.info), il sia pur ancora giovane Aristotele scrive che: “La filosofia offre una guida su come la ricerca deve essere condotta”. E, per ricerca, s’intende la ricerca scientifica promossa attraverso l’uso della mente. La filosofia dunque attiene, anche per il più giovane Aristotele, alla metodologia e quindi all’uso del metodo più confacente alla ricerca scientifica. Ovvero, come chiarisce lo stesso Rovelli: “aprire la mente degli scienziati” – e aggiungerei, non solo la mente degli scienziati, come nella cronaca odierna evidenziato a esempio dalla vicenda delle vaccinazioni imposta per legge – “a possibilità nuove”, sì da favorire la ricerca e conseguentemente acquisire nuove e più appropriate conoscenze.
 Che la filosofia costituisca piuttosto un metodo di ricerca è questione che inficia il rapporto della disciplina stessa con il concetto di “verità”. La relazione tra filosofia e verità è stata messa bene in luce, è stata cioè significativamente “dis-velata”, nel corso del secolo scorso, dall’opera di Heidegger. A tale proposito e per il prosieguo qui del discorso, il passo che segue a me pare estremamente esplicativo: “… Compreso in base all’imperiale, il verum si pone immediatamente come il rimanere in alto, che indica il retto; veritas è rectitudo, noi diciamo ‘correttezza’ (Richtigkeit). Ora, però, questa caratterizzazione originariamente romana dell’essenza della verità, che fissa il tratto fondamentale onnidominante della struttura essenziale dell’essenza della verità occidentale, accoglie spontaneamente uno sviluppo dell’essenza della verità che si profila già in seno alla grecità (n.d.r.: più avanti, nel testo, Heidegger aggiunge: “A partire da Platone, e soprattutto con il pensiero di Aristotele …”) e che contrassegna al tempo stesso l’esordio della metafisica occidentale”.
Che la filosofia costituisca piuttosto un metodo di ricerca è questione che inficia il rapporto della disciplina stessa con il concetto di “verità”. La relazione tra filosofia e verità è stata messa bene in luce, è stata cioè significativamente “dis-velata”, nel corso del secolo scorso, dall’opera di Heidegger. A tale proposito e per il prosieguo qui del discorso, il passo che segue a me pare estremamente esplicativo: “… Compreso in base all’imperiale, il verum si pone immediatamente come il rimanere in alto, che indica il retto; veritas è rectitudo, noi diciamo ‘correttezza’ (Richtigkeit). Ora, però, questa caratterizzazione originariamente romana dell’essenza della verità, che fissa il tratto fondamentale onnidominante della struttura essenziale dell’essenza della verità occidentale, accoglie spontaneamente uno sviluppo dell’essenza della verità che si profila già in seno alla grecità (n.d.r.: più avanti, nel testo, Heidegger aggiunge: “A partire da Platone, e soprattutto con il pensiero di Aristotele …”) e che contrassegna al tempo stesso l’esordio della metafisica occidentale”.
Dunque, attraverso il personaggio di Socrate, dalla fisica dei presocratici alla metafisica dei postsocratici. Con le conseguenze, derivanti dal cambio di metodo, che Plutarco espressamente, validamente ed efficacemente sottolinea: “… come dice Sofocle, anche le opere divine periscono, ma non gli dèi. ‘L’essenza e il potere di questi fenomeni vanno ricercati nella natura e nella materia, dicono i sapienti, salvaguardando però, come è giusto, la loro origine divina. È assurdo e puerile credere che il dio stesso, come i ventriloqui soprannominati un tempo Euricli e oggi Pitoni, entri nel corpo dei profeti e parli servendosi della loro bocca e della loro voce come strumenti. Chi mescola dio alle funzioni umane non rispetta la sua maestà, e offende la dignità e il prestigio della sua, superiore statura’. ‘Hai ragione’ disse Cleombroto. ‘Ma siccome è difficile comprendere e stabilire in qual modo e fino a che punto si possa far intervenire la provvidenza, succede che nell’opinione di alcuni il dio non c’entra per niente, per altri invece egli è la causa di tutte le cose senza eccezione. Ma né gli uni né gli altri tolgono la giusta misura. E dunque dice bene chi sostiene che Platone, presupponendo un elemento sottostante alle qualità in divenire – quello che viene chiamato oggi materia o natura – abbia liberato i filosofi da molte gravi difficoltà. Ma, a mio parere, molte difficoltà ancora più gravi sono state risolte da quelli che immaginarono il genere dei demoni, a metà fra dèi e uomini, il quale istituisce in certo modo un rapporto reciproco fra noi e la divinità. Poco importa se tale teoria si debba ai magi e a Zoroastro, o venga dalla Tracia e da Orfeo, oppure dall’Egitto o dalla Frigia, come testimoniano le cerimonie di questi due paesi, pervase dal lutto e dal senso della morte sia nei riti orgiastici sia nei drammi sacri’”.
In estrema sintesi, a seguito del pensiero introduttivo di Platone, la ricerca dell’ordine naturale della fisica veniva soppiantata dall’esordio della metafisica e la filosofia – conseguentemente all’atto imperiale definitivo dell’editto di Tessalonica (380 e.m.) e successivi decreti annessi – avrebbe assunto il ruolo e la funzione di “ancilla theologiae”. Quantum mutata ab illa!
Ma, riscoperto l’antico modo di fare filosofia, ha ancora senso oggi fare filosofia? Oggi, disvelato l’inganno della metafisica, è possibile restituire alla “condizione” attuale dell’umanità un modo di fare filosofia che configuri un orizzonte oltre che sia di senso compiuto? #Finiscoronatopus.
A far luce su questo interrogativo, ritengo illuminanti le considerazioni di due illustri pensatori francesi in voga maggiormente nella seconda metà del secolo scorso, Roland Barthes e Jean-Francois Lyotard; quest’ultimo, il teorico per eccellenza dell’attuale condizione postmoderna: da cui il passaggio storico da evo antico (e.a.) a evo moderno (e.m.) a evo postmoderno. Termine che qui introduciamo in maniera ancora ambigua e pertanto rappresenta il “nodo gordiano” che infine occorre piuttosto sciogliere: che cos’è, e soprattutto è possibile un destino nuovo della postmodernità? E se sì, qual è o sarebbe possibile?
Filtrato dal pensiero e dall’opera monumentale di Giorgio de Santillana, la considerazione di Barthes – che segue ed è relativa a poco oltre la metà del secolo scorso – lamentava la possibilità che in fondo venisse a mancare per l’umanità, tutta intera, un nuovo orizzonte di senso compiuto: “La mente ha abdicato, oppure si contrae in preda a un terrore apocalittico. In campo artistico si parla di amorfismo o ‘disintegrazione della forma’, di ‘trionfo dell’incoerenza’ nella poesia concreta e nella musica contemporanea. Le nuove sintesi, se ancora ve ne sono di possibili, si trovano oltre l’orizzonte”. Così, prendeva vigore e finiva con il consolidarsi la perdurante condizione postmoderna. Di cui Lyotard costituirà, di lì a breve, la massima espressione, almeno in Europa.
E, tuttavia, sarà proprio egli stesso ad aprire la possibilità di una nuova sintesi oltre l’orizzonte, nel suo ultimo saggio che prefigura il passaggio futuro dall’attuale condizione postmoderna a una condizione postumana. A tale proposito, con ottima sintesi, scrive Riccardo Campa: “Ecco allora emergere all’inizio degli anni novanta un Lyotard inedito, un Lyotard che non fa la sponda ai movimenti anti-progressisti, un Lyotard che mostra grande fiducia nelle possibilità del progresso tecnico-scientifico, un Lyotard che non profetizza un arresto o rallentamento del progresso, ma un futuro ipertecnologico che vede protagonista addirittura un essere postumano prodotto dalla scienza”. Perfettamente in linea con il ritorno dei fisici-scienziati e un antico modo di fare filosofia che abbia ancora un senso definitivo.
La qual cosa appare evidente; sia anche si consideri la preoccupazione dell’Arendt in chiusura al suo Vita activa, sia le prime applicazioni di carattere pratico che investono – secondo Giovanni Leghissa, l’autore citato qui per primo – le nuove vie possibili della scienza.
Così, l’Arendt: “Ma l’azione degli scienziati, poiché agisce nella natura della prospettiva dell’universo e non nel tessuto delle relazioni umane, manca del carattere di rivelazione dell’azione come della capacità di produrre vicende e storie, che insieme formano la fonte da cui scaturisce il significato che illumina l’esistenza umana. Da questo importantissimo punto di vista esistenziale, l’azione è diventata un’esperienza per pochi privilegiati, e questi pochi che ancora sanno che cosa voglia dire agire sono forse ancora meno degli artisti, e la loro esperienza ancor più rara della genuina esperienza e dell’amore per il mondo”.
Ma, è facile dimostrare che si sbagliava. Così infatti il Leghissa, a proposito del ruolo e della funzione “attivi” che la filosofia è di nuovo oggi chiamata a svolgere: “Il primo passo va in direzione di un posizionamento radicale dell’umano entro la dimensione dell’animalità – e qui l’uso dell’aggettivo ‘radicale’ non è enfatico: si tratta di negare la possibilità che vengano offerte spiegazioni non naturalistiche della storia umana e dei significati che all’interno di questa vengono prodotti (…) In stretta correlazione con il primo passo, ve n’è un secondo, che mira a declinare il ‘postumano’ entro una cornice etica volta a giustificare un rapporto paritetico con le altre specie (…) L’ultimo passo, infine, sarebbe quello in virtù del quale la nozione di ‘postumano’ indica la possibilità di un’accoglienza ospitale dell’artefatto, del cosale, dell’oggettuale. Qui è in gioco la messa in questione della infinita produttività dell’umano o del naturale”.
Ovvero, in conclusione, un destino postumano prefigurato da un modo originario di fare filosofia, il modo del pensiero “iniziale” che si pone costantemente al servizio della ricerca e della scoperta scientifica. Philosophia ancilla scientiae.



